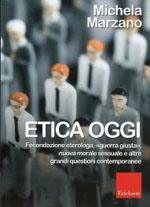Fecondazione medicalmente assistita, patologie geneticamente trasmissibili, consenso informato, rapporto medico-paziente, fine vita, condizioni degradanti negli ospedali psichiatrici giudiziari: prendendo spunto da un recente libro di Michela Marzano, pur non esplicitamente dedicato al tema "Etica e disabilità", proviamo a riflettere e a interrogarci su una serie di questioni in qualche modo connesse con la disabilità, tutte davvero delicate e importanti.
La copertina del libro di Michela Marzano da cui prende spunto Simona Lancioni per le sue riflessioniRecentemente è stato tradotto dal francese il testo di Michela Marzano L’éthique appliquée (Paris, PUF/Presses Universitaires de France, 2008), che in italiano è diventato Etica oggi (Trento, Erickson, 2011). Si tratta di un’opera che procede interrogandosi e che proprio nel porre domande (e che domande!), induce anche il lettore più distratto a concludere che, almeno sulle questioni etiche, al dubbio spetta un posto di riguardo. Il libro, come fa meglio capire il titolo originale, tratta appunto il tema dell’"etica applicata", prendendo in esame diverse situazioni di vita che sollevano problematiche di carattere morale. Si parla, ad esempio, di fecondazione assistita, del rapporto medico-paziente, del «diritto di morire», di etica ambientale, dei diritti dell’uomo, di «guerra giusta», di liberazione sessuale, di responsabilità sociale delle imprese. Un testo chiaro e sintetico che contiene tutti gli elementi essenziali a inquadrare le diverse tematiche. In esso non è toccato esplicitamente il tema Etica e disabilità e tuttavia, prendendo spunto dagli argomenti che vi si trattano e ritenendo che sondare questo binomio possa essere interessante, abbiamo iniziato a riflettere su alcune situazioni che sollevano questioni etiche e che, al contempo, sono in qualche modo connesse con la disabilità. Gli spunti e i quesiti che esse sollevano sono davvero tanti e importanti e se le risposte sono tutte da trovare, almeno iniziamo a interrogarci.
Il primo tema che sembra intimamente connesso con la disabilità è la fecondazione medicalmente assistita. In Italia questa materia ha trovato una disciplina giuridica con la Legge 40/04 che rispetto a quella di altri Paesi europei, è una normativa particolarmente restrittiva. La fecondazione medicalmente assistita è consentita infatti solo nei «casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»; è vietata la fecondazione eterologa e sono vietate le indagini pre-impianto dell’embrione (divieto dichiarato per altro illegittimo dalla Sentenza 151/09 della Corte Costituzionale). Vietata è infine – salvo casi eccezionali – anche la crioconservazione. Posto che non è corretto esprimere valutazioni senza tener conto delle specificità del contesto, è comunque difficile capire cosa renda il contesto italiano così particolare, da considerare inammissibili pratiche che sono legali appena varcati i confini nazionali. Non si capisce, ad esempio, perché solo chi è interessato da sterilità o da infertilità possa accedere a queste pratiche, e non anche – sempre ad esempio – chi è interessato da patologie geneticamente trasmissibili che hanno come esito disabilità importanti. Ferma la condanna delle pratiche eugenetiche, perché questi interventi non possono essere utilizzati per la prevenzione di alcune malattie? Inoltre, la norma del 2004 sembra sancire un diritto dell’embrione più forte di quello della donna e della coppia, ma una volta impiantato nell’utero materno, altre disposizioni normative (la Legge 194/78 sull’interruzione volontaria di gravidanza) stabiliscono l’esatto contrario: non è una contraddizione? Altra domanda di dubbia risposta: perché si può adottare il bambino di un’altra coppia, ma non una cellula uovo o uno spermatozoo?
Anche concetti come "consenso informato" e "rapporto medico-paziente" sembrano acquisire sfumature particolari quando si combinano con la disabilità. Marina Cometto, madre di Claudia, una donna con disabilità gravissima, ha dovuto aspettare trentotto anni per sapere che la disabilità della figlia è dovuta alla sindrome di Rett [anche il nostro sito ha dato spazio a questa storia. Se ne legga cliccando qui, N.d.R.]. Certo, non si può generalizzare, ma più le malattie sono rare, più il diritto ad essere informati sulla salute rischia di trasformarsi in una "caccia al tesoro" per chi ne è interessato (direttamente o per casi familiari), spesso senza nemmeno disporre di quel minimo di strumenti critici utili a valutare l’attendibilità e la trasparenza delle fonti informative consultate. Davanti a queste situazioni come può l’individuo compiere scelte consapevoli? Come può «accedere alla condizione di soggetto» di cui parla Marzano nel suo testo? (pagina 37 di Etica oggi). Negli anni scorsi due casi di cronaca hanno scosso l’opinione pubblica italiana imponendo una riflessione sui temi del fine vita: quello di Piergiorgio Welby (1) e quello di Eluana Englaro (2). Due casi molto diversi tra loro che hanno sollevato questioni etiche altrettanto diverse, ma che avevano in comune il fatto di cercare nella Legge e nel diritto una risposta a situazioni personali.
Davanti a queste due vicende ciò che ha colpito maggiormente è stata la generale impreparazione della società italiana nell’affrontare i temi posti dai casi in questione. Nei media e sul web prima, a livello istituzionale poi, era difficile trovare confronti ponderati e argomentati. Spesso, quelli che avrebbero dovuto essere confronti, erano più propriamente scontri che sarebbe riduttivo definire accesi.
Viviamo in una società in cui si parla poco e male di invecchiamento, malattia, disabilità, imperfezione e morte, dunque non desta sorpresa constatare questa generale impreparazione. Ciò che invece suscita sconcerto è il fatto che, una volta passata l’onda mediatica suscitata da casi eclatanti, la comunicazione su questi temi si incanali sui consueti binari. Cosa deve succedere per far capire che quelle vicende non riguardano singoli casi di persone estranee, ma interrogano la persona in quanto tale? Il 20 marzo 2011 la trasmissione televisiva Presa diretta ha mandato in onda uno scioccante documento della commissione d’inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale del Senato della Repubblica (visionabile cliccando qui), nel quale viene descritta la situazione terrificante in cui vivono i malati degli ospedali psichiatrici giudiziari. Il presidente della Repubblica Napolitano li ha definiti «luoghi indegni di un Paese appena appena civile». La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), la Costituzione della Repubblica Italiana (1948), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura e altri Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti (1984), la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (2006): gli strumenti per fermare l’orrore non mancherebbero, ma nessuno ancora è riuscito a fermarlo (3). Com’è possibile? La disabilità è un concetto in evoluzione. Negli ultimi anni le istanze delle persone con disabilità sono state inquadrate sempre più nell’ambito della rivendicazione dei diritti umani. Lo Stato Italiano, però, pur avendo ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità [Legge 18/09, N.d.R.], ha proseguito nella cancellazione progressiva del Fondo per le Politiche Sociali e di quello per la Non Autosufficienza. I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), cioè le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i Cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, sono aggiornati al 2001, mentre i Livelli Essenziali dell’Assistenza Sociale (LIVEAS), formalmente previsti nel 2000, non sono mai stati definiti. In tema di ausili, infine, siamo fermi al 1999. Sorge a questo punto un dubbio: la politica può permettersi di fare a meno dell’etica?
Fonte: Superando.it
11/01/2012